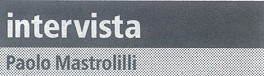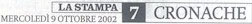
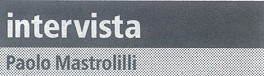
NEW YORK
QUANDO
gli americani, inguaribili ottimisti, vogliono dire che le possibilità di
realizzare qualcosa sono infinite, usano l'espressione «the sky is the limit»,
il limite è il cielo. Ma per Riccardo Giacconi, a 71 anni compiuti, la volta
celeste ancora non basta a fermarlo. Lui è venuto da Genova a Washington
proprio per dimostrare che si può andare oltre il cielo, e adesso coltiva un
grande sogno: «Contribuire a spiegare le origini della vita, e vedere se può
esistere in altri punti dell'universo». Ieri mattina il telefono è squillato
alle cinque e mezza, nella sua casa del Maryland, portando la notizia del premio
Nobel: «Era il presidente dell'Accademia reale svedese delle scienze, e da
allora in poi l'apparecchio non ha più smesso di suonare». Giacconi è felice
ma ancora sorpreso, quando lo raggiungiamo nel suo ufficio all'Associated
Universities Inc. di Washington: «Sono molto contento per mia moglie, per i
figli, e per il campo dell'astrofisica a cui ho dedicato la vita, perché in 40
anni è diventata una scienza molto importante. È un successo anche per la Nasa,
che ha sostenuto tanto il satellite Uhuru, lanciato dalla piattaforma italiana
San Marco in Kenya, quanto il telescopio Einstein, utilizzati per intercettare i
raggi all'origine del premio. Sono felice anche per me stesso, ma devo ancora
riflettere bene sul perché».
Lei è nato a Genova, si è laureato a Milano, ma è dovuto venire negli Stati
Uniti per realizzare le sue potenzialità. Cosa significa questo per la ricerca
in Italia?
«Se
è vero che la fase più creativa di uno scienziato è quella della gioventù,
bisognerebbe cercare di offrire il massimo delle opportunità ai giovani. Ai
miei tempi, negli Stati Uniti era più facile raggiungere i propri obiettivi che
non in Italia. Se un sistema è troppo chiuso, i nuovi talenti faticano ad
emergere. Non è tanto una questione del numero degli scienziati, quanto
piuttosto delle possibilità di lavoro».
Lei oggi tornerebbe in Italia a fare ricerca, oppure i suoi studi ormai sono ad
un livello troppo alto per condurli nel nostro paese?
«Non
siamo poi così stranieri! Io sono sempre rimasto in contatto con i colleghi
italiani ed europei, e per un periodo sono tornato a lavorare a Milano. Dal
punto di vista scientifico il gap non è enorme, e le persone intelligenti si
trovano dappertutto. Il problemaè avere la possibilità pratica di realizzare i
propri progetti».
In Italia, in sostanza, non si investono abbastanza soldi nella ricerca?
«È certamente un problema di risorse, ma anche di priorità. Cioè di scelte
su dove indirizzare le risorse».
La citazione del premio Nobel dice che «Riccardo Giacconi ha individuato per la
prima volta la fonte dei raggi X fuori dal nostro sistema solare, ed è stato il
primo a provare che l'universo contiene un background di radiazioni di raggi X.
Ha scoperto le fonti dei raggi X che secondo la maggior parte degli astronomi
contengono i buchi neri. Ha costruito il primo telescopio a raggi X, che ci ha
dato un'immagine completamente nuova e precisa dell'universo. I suoi contributi
hanno costruito le fondamenta dell'astronomia dei raggi X. Grazie a questa
scienza e ai suoi pionieri, in particolare Giacconi, la nostra immagine
dell'universo è cambiata in modo decisivo». Può spiegare cosa significa, ai
non addetti ai lavori?
«Ci
provo. Quando uno va dal medico gli fanni i raggi X, che sono una luce più
penetrante ed energetica di quella normalmente visibile. Dal nostro sole ne
riceviamo pochi, ma ci sono altre stelle nell'universo in cui la loro emissione
è il fattore predominante. La cosa più interessante è che i raggi X vengono
emessi quando ci sono delle esplosioni o dei fenomini molto energetici, e si
tratta di uno sviluppo tipico dell'universo. Ad esempio le stelle, quando
muoiono, vanno in un'esplosione di supernove, che producono raggi X.
Individuarli ci consente di studiare l'universo con una tecnica nuova,
differente rispetto a quella che si usa con le altre radiazioni. È molto utile
per la ricerca su fenomeni come le supernove, i campi magnetici, i buchi neri, e
questo punto di vista diverso, sommato agli altri, ci consente di avere
un'immagine piu' accurata dell'universo».
A cosa sta lavorando ora?
«Ad
un progetto chiamato Alma, che stiamo realizzando in collaborazione tra gli
Stati Uniti e l'Europa nel deserto Atacama del Cile, per sviluppare l'astronomia
millimetrica».
Quali sono gli obiettivi del progetto?
«Sono
principalmente due: lo studio della cosmologia a distanze molto grandi, sempre
attraverso il passaggio delle radiazioni, e l'analisi di come funzionano certe
molecole nello spazio, come si formano alcune particelle, e quindi anche come si
sviluppa la vita».
Vuol dire che tramite i suoi prossimi studi potreste fare nuova luce sulle
origini della vita, e magari sulla sua esistenza in altri punti dell'universo?
«Ci
sono molte cose interessanti che stanno succedendo, e stiamo chiarendo punti
importanti riguardo le altre stelle. Abbiamo scoperto la presenza di materiali
organici fuori dal sistema solare, ad esempio nella forma aldeide. Come poi
questi materiali passino nel nostro sistema e diano origine alla vita è ancora
poco chiaro, ma la scoperta in se' apre enormi possibilita' di ricerca, che per
ora non escludono alcuno sviluppo».
Davanti a progetti tanto interessanti ed ambiziosi, viene la curiosità di
chiederle se lei crede in Dio.
«È
un argomento complicato, a cui preferirei non rispondere. Diciamo che non sono
convinto della sua presenza in un luogo determinato. Ma se mi chiedete se penso
che ci sia qualcosa di superiore nell'universo, sotto qualche forma, la risposta
è sì».
Cosa farà con i soldi del premio?
«Ci
pagherò l'istruzione dei miei nipoti: visti i costi di oggi, basteranno giusto
a questo».
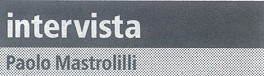
![]()